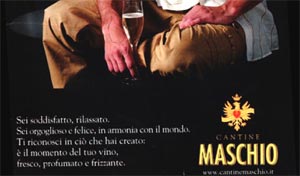Usi Epressivi della lingua: differenze tra le versioni
| Riga 1: | Riga 1: | ||
[[categoria: Semiotica]] | [[categoria: Semiotica]] | ||
| − | + | Argomento: Usi espressivi della lingua | |
==Descrizione== | ==Descrizione== | ||
| + | L’uso delle iconiche del linguaggio si nota quando si ha l’attenzione sull’espressione invece che nel ruolo funzionalistico (discorso scientifico, legale, militare ecc.). | ||
| − | + | La parola, praticamente, deve essere “bella”, “pittorica”, “vivida”, che non costituisce solo un supporto al significato, ma di assumerlo cercando di essere un linguaggio estetico. | |
| − | + | Questi possono essere: | |
| − | + | • Linguaggio poetico | |
| − | + | • Linguaggio persuasorio della pubblicità | |
| − | + | • Linguaggio della musica vocale | |
| − | + | Iconismo e poesia | |
| + | Nella parola che si usa comunemente, conta poco la sua materialità, come in una moneta il suo aspetto, rispetto al suo valore. | ||
| + | La poesia, in poche parole nega la visione funzionalistica e ne riscatta la materialità. | ||
| − | + | Il carattere autoriflessivo o autotelico del messaggio poetico accentua la sua attenzione sulla struttura dell’espressione. | |
| − | + | Sartre afferma che il poeta considera le parole come cose e non come segni. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Se la parola è come una moneta per scambiare i pensieri, seguendo un’immagine di Raymond, il poeta “intende pagare in natura”. | |
| − | + | Nelle poesie di Fosco Maraini si trovano molti esempi di poesie che usano neologismi, sfruttando le valenze iconiche, la carica espressiva. | |
| − | + | In esse si nota l’uso delle leggi espressive del fonosimbolismo. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | Linguaggio iconico e musica | ||
| − | + | I contenutisti, al contrario dei formalisti, attribuiscono alla sostanza musicale un valore semantico. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Come base dell’espressività, per quest’ultimi ci sono “schemi motori” attivati dai toni e ritmi musicali, con tratti analoghi al fonosimbolismo. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Quindi l’incontro tra parola e musica è molto fecondo, quest’incontro si trova nel canto dove l’espressività della parole è potenziata dalla musica e dalla | |
| − | + | gestualità. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | + | Iconismo e pubblicità | |
| − | + | Lo scopo del messaggio pubblicitario è quella persuasoria, che colpisce l’attenzione per farsi percepire sulle altre comunicazioni. | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| + | Quindi fondamentale è cercare tutti gli artefici per rendere più allettante il messaggio. | ||
| + | Le caratteristiche dei beni sono equivalenti, quindi il messaggio passa da tratti denotativi a connotativi e da razionali ad emotivi. | ||
| + | Da argomenti logici sul prodotto si passa a sensazioni, forme iconiche dove la lingua crea nell’espressione stessa le caratteristiche di attrattività e fascino degli oggetti grazie a varie forme di iconismo verbale. | ||
| − | + | Tra le tecniche per rendere più vicino il prodotto, l’abbreviare è un modo per rendere il prodotto più simpatico. | |
| − | + | Esempio: | |
| − | + | Pomì = marca di pomodori | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | Per aumentare la qualità dell’oggetto, si usano superlativi, in modo che possa essere ancora piu desiderato… | |
| − | + | Esempio: Piacere extralarge, Tutti extra, Extra sexy, Extra sicura, extra soft, | |
| − | + | extra sensation, extraordinaria, extra successo ecc… | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | |||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Image: mas.jpg |center|frame|Cantine Maschio]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | Nel nome del prodotto si usano parole che riprendono, in modo iconico verbale o tramite onomatopee, le sue caratteristiche. | ||
| + | Volvo, crostatine, clic-clac. | ||
| + | O Verbo-visivi con icone marginali o che invadono l’intera parola. | ||
| + | |||
| + | |||
==Bibliografia== | ==Bibliografia== | ||
| − | Fernando Dogana Le parole dell’Incanto | + | Fernando Dogana Le parole dell’Incanto Franco Angeli Editore |
| − | + | Arnheim, R. (1986b) Linguaggio, immagine e poesia concreta, in R. Arnheim, Intuizione e intelletto, tr. it. Feltrinelli, Milano 1987, pp. 112-124. | |
| − | + | F. Dogana, Suono e Senso. Fondamenti Empirici del Simbolismo Fonetico, Angeli 1988 | |
| − | + | Giovanni Pozzi La Parola dipinta Adelphi - Collana: Ramo d'oro | |
| + | Paola Desideri La pubblicità tra lingua e icona, Ancona, Humana Editrice, 1996, pp. 163. | ||
| + | N. CHOMSKY, 1994, Il potere dei media, Firenze, Vallecchi. | ||
| + | G. AMBROSIO, 2002, Siamo quel che diciamo. Il pensiero di qualità in pubblicità, Roma Meltemi. | ||
| + | “Linguaggio, regole e pubblicità”, in Forme e linguaggi della filosofia. Scritti per Filippo Costa, a c. di N. De Domenico et al., Dipartimento di Filosofia, Storia e Critica dei Saperi, Palermo 1999, pp. 371-398. | ||
| + | |||
==Webliografia== | ==Webliografia== | ||
| − | + | www.associazionesemiotica.it/ eventi/eventi_v_d_no_relatore.php?recordID=77 - 26k – | |
| − | + | http://www.interculturemap.org/IT/education/analyses_education.php?analyses_id=34 | |
| − | www. | + | http://forum.accademiadellacrusca.it/forum_12/interventi/5016.shtml |
| − | http:// | + | www.lettere.unipa.it/campusblog/ media/1/tacchiaspillo.pdf |
| + | http://scienzecognitive.unime.it/filling/pubblicazioni.html | ||
Revisione 02:56, 9 Mar 2007
Argomento: Usi espressivi della lingua
Descrizione
L’uso delle iconiche del linguaggio si nota quando si ha l’attenzione sull’espressione invece che nel ruolo funzionalistico (discorso scientifico, legale, militare ecc.).
La parola, praticamente, deve essere “bella”, “pittorica”, “vivida”, che non costituisce solo un supporto al significato, ma di assumerlo cercando di essere un linguaggio estetico.
Questi possono essere:
• Linguaggio poetico
• Linguaggio persuasorio della pubblicità
• Linguaggio della musica vocale
Iconismo e poesia Nella parola che si usa comunemente, conta poco la sua materialità, come in una moneta il suo aspetto, rispetto al suo valore. La poesia, in poche parole nega la visione funzionalistica e ne riscatta la materialità.
Il carattere autoriflessivo o autotelico del messaggio poetico accentua la sua attenzione sulla struttura dell’espressione.
Sartre afferma che il poeta considera le parole come cose e non come segni.
Se la parola è come una moneta per scambiare i pensieri, seguendo un’immagine di Raymond, il poeta “intende pagare in natura”.
Nelle poesie di Fosco Maraini si trovano molti esempi di poesie che usano neologismi, sfruttando le valenze iconiche, la carica espressiva. In esse si nota l’uso delle leggi espressive del fonosimbolismo.
Linguaggio iconico e musica
I contenutisti, al contrario dei formalisti, attribuiscono alla sostanza musicale un valore semantico.
Come base dell’espressività, per quest’ultimi ci sono “schemi motori” attivati dai toni e ritmi musicali, con tratti analoghi al fonosimbolismo.
Quindi l’incontro tra parola e musica è molto fecondo, quest’incontro si trova nel canto dove l’espressività della parole è potenziata dalla musica e dalla gestualità.
Iconismo e pubblicità Lo scopo del messaggio pubblicitario è quella persuasoria, che colpisce l’attenzione per farsi percepire sulle altre comunicazioni.
Quindi fondamentale è cercare tutti gli artefici per rendere più allettante il messaggio.
Le caratteristiche dei beni sono equivalenti, quindi il messaggio passa da tratti denotativi a connotativi e da razionali ad emotivi.
Da argomenti logici sul prodotto si passa a sensazioni, forme iconiche dove la lingua crea nell’espressione stessa le caratteristiche di attrattività e fascino degli oggetti grazie a varie forme di iconismo verbale.
Tra le tecniche per rendere più vicino il prodotto, l’abbreviare è un modo per rendere il prodotto più simpatico. Esempio: Pomì = marca di pomodori
Per aumentare la qualità dell’oggetto, si usano superlativi, in modo che possa essere ancora piu desiderato… Esempio: Piacere extralarge, Tutti extra, Extra sexy, Extra sicura, extra soft, extra sensation, extraordinaria, extra successo ecc…
Nel nome del prodotto si usano parole che riprendono, in modo iconico verbale o tramite onomatopee, le sue caratteristiche.
Volvo, crostatine, clic-clac.
O Verbo-visivi con icone marginali o che invadono l’intera parola.
Bibliografia
Fernando Dogana Le parole dell’Incanto Franco Angeli Editore Arnheim, R. (1986b) Linguaggio, immagine e poesia concreta, in R. Arnheim, Intuizione e intelletto, tr. it. Feltrinelli, Milano 1987, pp. 112-124. F. Dogana, Suono e Senso. Fondamenti Empirici del Simbolismo Fonetico, Angeli 1988 Giovanni Pozzi La Parola dipinta Adelphi - Collana: Ramo d'oro Paola Desideri La pubblicità tra lingua e icona, Ancona, Humana Editrice, 1996, pp. 163. N. CHOMSKY, 1994, Il potere dei media, Firenze, Vallecchi. G. AMBROSIO, 2002, Siamo quel che diciamo. Il pensiero di qualità in pubblicità, Roma Meltemi. “Linguaggio, regole e pubblicità”, in Forme e linguaggi della filosofia. Scritti per Filippo Costa, a c. di N. De Domenico et al., Dipartimento di Filosofia, Storia e Critica dei Saperi, Palermo 1999, pp. 371-398.
Webliografia
www.associazionesemiotica.it/ eventi/eventi_v_d_no_relatore.php?recordID=77 - 26k – http://www.interculturemap.org/IT/education/analyses_education.php?analyses_id=34 http://forum.accademiadellacrusca.it/forum_12/interventi/5016.shtml www.lettere.unipa.it/campusblog/ media/1/tacchiaspillo.pdf http://scienzecognitive.unime.it/filling/pubblicazioni.html